Vorrei parlavi oggi di tre concetti: il senso, l’equilibrio e il futuro. Per farlo vi parlerò anche delle tre barriere che ci impediscono di realizzare questi tre concetti: la routine, l’ingordigia e la miopia. E infine vi parlerò di tre antidoti che possono aiutarci a superare le barriere e a cambiare le nostre aziende (e forse non solo) in un luogo migliore: la cultura, l’apertura e l’ambizione.
***
Cominciamo dal primo concetto: il senso, il significato.
Qual è il senso del nostro mestiere?
Se fossimo stati qui a farci la stessa domanda nel 1955, la risposta sarebbe stata semplice.
Dopo la seconda guerra mondiale, in pochi anni, insieme a una buona politica, le nostre imprese hanno distribuito prodotti di consumo e beni durevoli, che prima erano riservati a pochi (carne, pesce, burro, latte, caffè, zucchero) o che prima non esistevano affatto (lavatrici, frigoriferi, automobili) a decine di milioni di italiani, aiutando la popolazione a crescere da 45 a oltre 56 milioni di abitanti, allungando la vita media di circa due decenni, azzerando la mortalità infantile, rendendo migliore e più vivibile la vecchiaia, moltiplicando nel contempo il reddito nazionale per 5.
In questa fase storica, insomma, tre cose fondamentali progredirono di pari passo: sviluppo industriale e lavoro, crescita economica e dei consumi e progresso ed eguaglianza sociale (non perfetta certamente ma quantomeno costante). Ecco allora che chi faceva il nostro mestiere trovava un senso, un significato che era più che economico. Il senso di partecipare a un percorso collettivo di miglioramento, di progresso, in cui tutti (o quasi) ci guadagnavano qualcosa. La filosofia e l’ideologia ispiravano la politica che governava l’economia che si serviva della finanza.
Ma oggi non siamo nel 1955. E dobbiamo domandarci qual è il ruolo dell’industria di marca oggi? Qual è il senso oggi di convincere le persone a comprare prodotti di cui non hanno più bisogno, in un mondo che non ha più le risorse per produrli?
Qual è il senso di far parte di un meccanismo che secondo il WWF oggi immette in atmosfera 55 giga-tonnellate di CO2 equivalenti, contro le meno di 40 del 1990; che secondo Greenpeace impiegherà meno di 80 anni per aumentare la temperatura della terra tra 1,8 e 4 gradi, e che secondo lo Stockholm International Water Institute entro il 2030 creerà al 47% della popolazione mondiale problemi di scarsità di acqua.
Qual è il senso di far parte di una generazione che secondo lo Us Bureau of Economic Analysis nell’ultima quindicina di anni ha portato i profitti delle aziende americane da meno di 400 miliardi di dollari di inizio secolo alla cifra record di duemila miliardi dei giorni nostri, mentre per esempio in Italia, secondo il World Inequality Report 2018, tra il 1993 e il 2013 il 90 per cento più povero della popolazione ha visto scendere la propria ricchezza dal 60 al 45 per cento?
Siamo di fronte a una crisi di senso. Per questo solo in Italia ci sono 6 milioni di persone che soffrono di stress da lavoro: perché non capiscono più il senso di quello che fanno.
Lo psicoanalista Luigi Zoia scrive: “Siamo pieni di persone intellettualmente capaci che fanno cose stupide: non perché le cose che fanno siano stupide in sé, ma perché non sono pensate da loro e non rispondono ai loro bisogni. Sono le ripetizioni di atteggiamenti collettivi”.
L’uomo per essere felice ha bisogno di trovare un senso, un significato in quello che fa. E non sono sicuro che oggi la risposta alla domanda di senso sia così ovvia.
***
Secondo concetto: equilibrio. In azienda siamo molto più abituati a parlare di “vantaggio” che di “equilibrio”. Ma la parola “vantaggio” è parente stretta della parola “accumulo”, perché chi vince accumula e chi perde scompare. Il vantaggio competitivo è sano, perché produce innovazione, qualità ed efficienza. Ma, se si esagera con questa grammatica del vantaggio, si rischia di diventare “rapaci” e di snaturare i rapporti stessi che tengono in piedi un’azienda e soprattutto si altera la distribuzione del valore lungo la filiera. E l’azienda si trasforma dalla “gallina dalle uova d’oro” in un feroce rapace che ruba a tutti per consegnare a pochi.
Il vero obiettivo di un’impresa dovrebbe essere quello dell’equilibrio. “Equilibrio” mi sembra un concetto quotidiano, semplice, comprensibile per tutti. “Equilibrio” non significa stare fermi, ma muoversi con rispetto.
Se il ruolo dell’azienda all’interno della società è in equilibrio, l’azienda potrà continuare a vivere a lungo e insieme a essa prospereranno i suoi fornitori, i suoi dipendenti, i suoi clienti e le comunità che vivono intorno ai suoi luoghi di produzione. Se un’azienda, al contrario, perseguirà il vantaggio e non l’equilibrio, accaparrerà risorse, sfrutterà, ridurrà il valore delle cose che compra per aumentare i profitti. E tutto questo produrrà scompensi. Nello spazio o nel tempo. E a lungo andare lo squilibrio creato dal rapace si ritorcerà contro di lui. I migliori fornitori lavoreranno per altri; i migliori talenti cercheranno aziende migliori per cui lavorare; le comunità locali non saranno partner del suo sviluppo. “Equilibrio” è la parola magica, non “vantaggio”.
***
Terzo concetto: futuro. Le aziende sono piene di “termini e scadenze”: il mese, il trimestre, l’anno, il 3 year plan. Ma cosa significa la parola “termine”? La parola “termine” indica il momento in cui qualche cosa cessa di esistere. In questo senso è sinonimo di “fine”. Quando in azienda si vuole apparire lungimiranti si propone sempre di guardare al “lungo termine” e non di focalizzarsi sul “breve”. Ma sia esso breve o lungo il termine è sempre un termine, una fine. È una scadenza.
“Futuro” invece viene dal participio futuro (appunto) del verbo essere. E già in questo si sente la differenza tra qualcosa che è e che sarà e qualcosa che invece cesserà di essere. Il mio conterraneo Brunello Cucinelli sostiene che l’impresa deve tornare a progettare sì a tre mesi; ma anche a tre anni, a trent’anni, a tre secoli.
Gli imprenditori sono “animali da futuro”. Orientare un’impresa al futuro è ben altra cosa che orientarla al lungo termine. Progettarla per il lungo termine vuol dire prolungarne la scadenza. Orientarla al futuro significa progettarne l’eternità.
***
Ecco dunque i tre concetti: senso, equilibrio e futuro. Tre parole ovvie. Ma allora perché sono altre le parole che guidano il nostro agire quotidiano?
Perché ci sono tre barriere che ci costringono a occuparci di cose di cui non ricordiamo il senso, che ci inducono ad accaparrare senza rispetto e che ci spingono verso il breve termine.
***
La prima barriera è la routine. È la routine che ci impedisce di farci le domande sul senso, sul significato di quello che facciamo. La routine assorbe il nostro tempo, riempie i nostri spazi. La routine è comoda. Pone domande semplici. O se sono difficili sono comunque simili a se stesse (come chiudiamo il contratto con Conad quest’anno?). La routine è la nostra coperta di Linus.
Prendiamo il caso dell’innovazione. Ogni anno nel largo consumo in Europa si lanciano circa 20-30mila prodotti nuovi. Circa il 56% muoiono prima dei 6 mesi di vita. Circa il 90% muoiono prima dei 12 mesi vita. Secondo Nielsen l’80% dei lanci nel 2015 ha generato in media meno di 9mila euro di fatturato a scaffale. 9mila euro, meno trade margin, meno iva…! Che senso ha tutto questo? Ha il senso della routine. Tutti lo sappiamo, fornitori e clienti, ma tutti continuiamo a farlo. Quei prodotti servono a pareggiare la controcifra, che includeva altri 20-30 mila prodotti inutili lanciati l’anno prima, a non perdere lo spazio a scaffale, la ponderata…
Ma che senso ha tutto ciò? La routine ci aiuta a non porci questo problema, perché io dopo questo bel discorso rientrerò in azienda e chiederò ai miei quali nuovi prodotti lanceremo l’anno prossimo e voi farete altrettanto. E andremo avanti così. Perché chi si ferma è perduto.
Poi però si tirano su le reti e si guardano quanti pesci sono nella rete. E si scopre che i piani strategici delle aziende sono pieni di innovazione mentre il core business è sempre destinato a declinare. I dati actual però raccontano sempre un’altra storia: core business che va sempre meglio del budget e nuovi prodotti che vanno sempre peggio del piano. La routine. La routine è l’opposto dell’innovazione. È come l’edera. È bellissima quando nasce e cresce. Ma poi se lasci che copra le finestre e le porte e il tetto la casa diventa buia e l’aria irrespirabile.
La routine è il nemico che ci impedisce di occuparci del senso di ciò che facciamo.
***
La barriera invece che ci impedisce di occuparci di equilibro è l’ingordigia. Distinguere l’ambizione dall’ingordigia in azienda è difficile. Se si è convinti che il proprio prodotto è davvero il migliore del mondo e che può cambiare in meglio la vita delle persone, si avrà l’ambizione di volerlo vendere a più persone possibile. Pensate a chi per primo ha messo la pasta in un box di cartoncino per farne la regina della cucina, a chi ha messo il tonno in una scatola e lo ha reso così tenero che si taglia con un grissino, a chi è riuscito a mettere il caffè liquido dentro una cialda di cioccolato, a chi è riuscito a mettere 1000 canzoni in una tasca di milioni di persone in tutto il mondo. Imprenditori geniali, che avevano l’ambizione di fare sempre meglio e sempre di più. Ma l’ingordigia è un’altra cosa. L’ingordigia vuol dire invertire l’ordine dei termini: “ricavi – costi = profitto”, recita la micro-economia classica. Si parte dal ricavo, cioè dal prodotto, cioè dall’idea che c’è dietro, cioè dalle persone cui si vuole offrire una soluzione nuova e migliore. Poi si ottimizzano i costi, e così si ottiene il profitto, che servirà a investire in nuove fabbriche per continuare a crescere e a dare lavoro. Non si parte dal profitto! Chi vuole partire dal profitto farà bene a fare un altro mestiere, non l’industriale. Ci sono strade più brevi, più facili. La nostra strada, quella dell’industria di marca, non è quella più corta.
Per noi la crescita è risultato e il profitto il premio. La nostra è l’etica del prodotto, l’etica del lavoro.
Non è un percorso per gli ingordi.
***
Ora parliamo di ciò che impedisce di occuparci del terzo concetto, quello più importante, il futuro. Qui il nemico si chiama miopia.
La miopia è un difetto individuale e collettivo allo stesso tempo, che in azienda può diventare sistemico. Individuale, perché, ci piaccia o no, esistono persone che hanno un orizzonte più ampio di altre, un respiro più lungo, un orizzonte più vasto. È una questione di background, di coraggio, di autostima, di sicurezza di sé, non so, ma è così. Ma è anche un problema collettivo, perché esistono culture organizzative più orientate al breve termine di altre, culture che accettano l’errore meglio di altre, che considerano il fallimento come un passo necessario in un percorso lungo. La miopia infine è un male sistemico, perché quando le inclinazioni individuali si fanno cultura organizzativa e informano di sé i processi aziendali, i sistemi, i KPIs, ecco che tutto il sistema azienda si fa miope, conservatore, prudente, con la vista corta, appunto.
La miopia non consente di vedere avanti. E se il futuro non lo guardi in faccia, non puoi capirlo né tanto meno puoi realizzarlo.
Quando si è di fronte a un cambiamento occorre guardare lontano, se si guarda vicino, non si va oltre la propria ombra. Occorre girare lo sguardo verso la nuova direzione: se si continua a guardare le stesse cose con gli stessi occhi non si cambierà nulla. O si cambiano gli occhi o le cose che guardiamo. A un certo punto, poi, occorre accelerare al massimo, perché altrimenti non si prende la velocità necessaria. I leader dovrebbero occuparsi principalmente di quello che non c’è, lasciando la gestione di quello che c’è ad altri! La miopia non ci consente di fare nessuna di queste cose.
Fin qui le barriere dunque.
***
E quindi, come si fa?
Come si fa a superare le barriere (la routine, l’ingordigia e la miopia) e focalizzarci sulle cose che contano, mantenere viva la ricerca di senso in ciò che facciamo, ricercare l’equilibrio e orientare le imprese al futuro?
È una domanda troppo grande per poter avere una risposta semplice. Ma cerchiamo almeno di iniettare nelle vene delle nostre aziende degli antidoti.
Il primo antidoto contro la routine è la cultura. Si la cultura! Perché ci sono cose che non vanno mai fori moda. E la cultura è certamente una di queste.
Perché la cultura generale, non specialistica, non tecnica, può aiutare i manager a ricordarsi che sono persone. La cultura umanistica, le discipline umanistiche, sociali, possono aiutare i manager a ricordarsi che anche i loro collaboratori sono esseri umani e anche i consumatori e anche i fornitori. Insomma, un manager che legge qualcosa di psicologia, di filosofia, di storia, di sociologia è un manager che può inserire il suo agire manageriale in un contesto più ampio. Può in questo modo ricordarsi che le aziende sono reti sociali e non fogli excel e che i prodotti che lanciamo si inseriscono nel mondo e non solo in uno scaffale, e che dal mondo prelevano risorse e in esso spargono i propri rifiuti. Può meglio ricordarsi che le persone non vengono al lavoro per lo stipendio ma per cercare un significato nella loro vita. E può quindi cercare di aiutarle a trovare quel significato in qualcosa che vada oltre la sola e semplice dimensione tecnico-economica del loro agire.
Diceva Adriano Olivetti nel 1955 “Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? La nostra società crede perciò nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura […]. Crede soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto”. Non è poesia. Quest’uomo con questi principi ha fatto anche business e meglio degli americani. Ogni tre neo-laureati assunti, uno doveva essere laureato in discipline umanistiche, uno in ingegneria e uno in economia. Il principio della terna, lo chiamavano nella grande Olivetti.
Poi ce lo siamo dimenticati. Ora siamo tutti esperti dei “come”, e ci siamo dimenticati di chiederci i “perché”. Siamo diventati specialisti di tutto, ma non conosciamo più noi stessi, non conosciamo più gli uomini. E poi, anche per questo motivo, assumiamo consulenti, esperti e formatori, per ogni cosa. Bisogna insegnare tutto. A parlare, a scrivere, a dare feedback, a strutturare il pensiero, a risolvere problemi, a distinguere tra fatti e opinioni, a capire la diversità dell’altro e a includerla nel proprio modo di pensare, a motivare gli altri, ad aiutarli a capire se stessi e a trovare la propria strada.
Insegniamo il valore della diversità a persone che non hanno mai aperto un libro di filosofia. E a tenere questi corsi non chiamiamo i filosofi ma i consulenti americani. Troppa tecnica, poca saggezza o, all’opposto, poca temerarietà!
Primo antidoto, dunque: un po’ di cultura generale, che ci aiuti a tenere acceso il cervello, a relativizzare le nostre piccole vicende professionali, ricordandoci che esiste un contesto, e inducendoci a ricercare un senso più profondo, rispetto a quello apparente, in quello che facciamo ogni giorno.
***
Secondo antidoto, stavolta contro la malattia dell’ingordigia: l’apertura.
Perché l’apertura contro l’ingordigia e non per esempio la generosità? Perché io non credo che le aziende, anche quelle più ingorde, siano popolate di persone ingorde, ma di persone chiuse. È la chiusura la fonte dell’ingordigia delle aziende non l’ingordigia dei manager. La chiusura nei nostri paradigmi. La chiusura tra simili che si legittimano e si giustificano reciprocamente.
E allora l’antidoto non è la generosità ma l’apertura. Perché essere aperti vuol dire essere permeabili alle istanze di chi ci sta intorno. Di chi non ha i nostri stessi interessi. Se guidiamo un’azienda alimentare, per esempio, essere aperti significa avere un rapporto quotidiano, strutturato e trasparente con le organizzazioni dei fornitori (che spesso sono rappresentanti del mondo dell’agricoltura per esempio e hanno interessi a volte opposti ai nostri) o con le ONG, che per mestiere fanno le pulci a tutta la nostra supply chain e ci aiutano a migliorarci. Essere aperti significa ascoltare le persone che lavorano in azienda, a prescindere dal loro livello gerarchico, perché se “il re è nudo” sarà sempre un bambino a dirlo.
E allora apriamo i nostri uffici, facciamo fluire le opinioni; apriamo le nostre agende, lasciamo tempo libero per parlare e per pensare; apriamo le aziende stesse e lasciamo che esterni entrino dentro i nostri processi.
Come risultato, le aziende si irrobustiranno. E troveranno un maggiore e migliore equilibrio. Anziché poggiare solo su un pilastro, quello degli azionisti e dei manager, cominceranno a poggiare anche su altri pilastri: la comunità in cui operiamo, i giovani che lavorano in azienda, le associazioni di categoria, le ONG.
Tutti questi attori pretendono equilibrio da noi (non si può massimizzare solo l’interesse dell’azionista) ma restituiscono equilibrio sotto forma di maggiore stabilità.
***
E arriviamo così in fondo. Qual è l’antidoto contro la miopia?
Credo che non ci sia antidoto migliore dell’ambizione.
Anche l’ambizione è individuale, collettiva e sistemica. Ma tutto nasce dagli individui. Circondiamoci di gente ambiziosa. Non ambiziosa per sé. Ma ambiziosa per gli altri. Ambiziosa di cambiare le cose in meglio, per tutti. La mia personalissima definizione di General Management è “l’arte di rovesciare i sassi”. Se vuoi guidare un’azienda devi essere uno che rovescia i sassi, per trovare le opportunità e per sistemarli lungo un percorso nuovo. Se ti limiti a camminarci, sui sassi, guidare un’azienda non è il tuo mestiere.
Gente ambiziosa, che guarda avanti. Ottimisti intelligenti. Non a caso Sallustio diceva che “l’ambizione, tra tutti i vizi umani, è quella che assomiglia maggiormente a una virtù”.
Ma l’ambizione non è solo una virtù individuale, è anche una virtù collettiva e può diventare quindi sistemica.
Persone di Amazon mi raccontavano dei loro grandi errori, di cui nessuno parla più. Chi di noi ricorda lo smartphone “Fire Phone”, sul quale Amazon aveva investito 170 milioni di dollari o “Amazon Auctions”, un sito per aste che avrebbe dovuto far dimenticare “ebay” e che invece è fallito quasi subito, o “Junglee”, un sito per confrontare i prezzi. Tutti conoscono i grandi successi di Amazon: Prime, Prime Now, Fresh e tutto il resto. Ma nessuno ricorda gli insuccessi, anche clamorosi. E costosissimi. “L’invenzione e il fallimento sono gemelli inseparabili” spiega Bezos in una lettera agli azionisti. È un fatto culturale, dunque sistemico: si chiama propensione al rischio e si può iniettare nei processi aziendali, sia nei processi di business che in quelli HR.
“Un errore compiuto nella direzione giusta, non è un errore” – mi disse una volta un mio capo particolarmente ambizioso.
Significa per esempio domandarsi che prodotti possiamo vendere tra 10 anni che diventino più grandi di quelli che vendiamo oggi e non che prodotti possiamo lanciare l’anno prossimo per fare il budget. Significa, quando si sviluppa un nuovo packaging o una nuova pubblicità, pretendere che siano i più belli della storia di quella marca e non fare il meglio per rispettare la finestra di lancio.
***
Vi ho parlato dunque di senso, di equilibrio e di futuro. Dei nemici di questi tre concetti: routine, ingordigia e miopia e dei tre possibili antidoti: cultura, apertura, ambizione.
Vorrei però concludere parlando di ciò che ci unisce tutti in questa sala, la marca: le marche che ruolo hanno in questo dibattito? Possono aiutarci a risolvere questi problemi?
Credo assolutamente di sì.
Se il nostro problema è quello di non pensare sufficientemente al futuro e di essere schiacciati da un presente asfittico, la marca aiuta, perché la marca è un manifesto di un mondo possibile, le marche sono dei partiti politici che propongono valori, fondano movimenti, offrono significati e segni che le persone prendono in prestito per costruire i loro significati e il loro mondo. Le marche sono “pezzi di futuro” possibile.
Se il nostro problema è che le aziende sono diventate strutture non pensanti, le marche aiutano, perché le marche forzano le aziende, anziché sviluppare prodotti e poi domandarsi a chi venderli, a immaginare dei mondi possibili e poi a inventare prodotti che si inseriscano in quei mondi, realizzandone i valori. Le marche sono proteine nobili delle nostre aziende che ne rafforzano i tessuti pensanti.
Se il nostro problema è restituire al nostro agire e al nostro essere manageriale più spessore, più cultura, le marche aiutano, perché le marche ancorano i nostri prodotti alla società e al costume, alla cultura dunque, conferiscono loro profondità. Una marca senza prodotti eccezionali è come una promessa elettorale irrealizzabile. Ma non dimentichiamoci che un prodotto (per quanto buono esso sia) senza una marca rilevante “dietro” è un oggetto non identificato che si perde nella seconda pagina di una ricerca di Google. Il purpose di una marca può fare più per la strategia HR di un’azienda di mille corsi di formazione. Le marche sono cultura aziendale. Recuperiamone la profondità.
Se il nostro problema è recuperare ambizione nel nostro mestiere, affidiamoci alle marche, alle loro promesse, ai loro racconti possibili, alle storie meravigliose che raccontano. Le marche sono inviti a migliorare il mondo, con coraggio e ambizione.
Se il nostro problema, infine, è un mondo in cui le risorse vengono sfruttate e sprecate e in cui il valore non è ben distribuito, riscopriamo il valore della marca, che in fondo non è altro che un grandissimo patto di fiducia nel tempo, che lega insieme una filiera e i suoi consumatori, con rispetto, senso di responsabilità e voglia di futuro.
Chi lavora in un’industria di marca è un privilegiato. In una comunità di business in cui si fa fatica a trovare un senso, si perde il senso di futuro, si perde l’ambizione, noi siamo custodi del tesoro più prezioso: le marche.
E noi in Italia, in particolare, siamo privilegiati tra i privilegiati: così ricchi di incredibili storie imprenditoriali, di prodotti eccellenti, che sono diventati marche, che affascinano milioni di persone in tutto il mondo e che possono offrire a tutti una proposta migliore per un futuro più bello, dove cultura, apertura e ambizione possano contribuire davvero a ritrovare un senso più profondo al nostro mestiere, un equilibrio più sostenibile per le nostre aziende e un futuro migliore per chi verrà dopo di noi.
 Intervento a Centromarca, ottobre 2018.
Intervento a Centromarca, ottobre 2018.
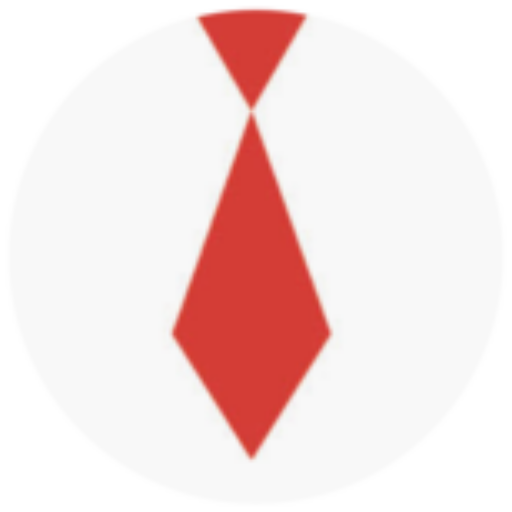

Illuminato e accorato, realistico e filante. Grazie per aver messo tutto in una tabella.
Giuseppe Morici si conferma un open minds…sempre bello da leggere, sempre interessante per riflettere