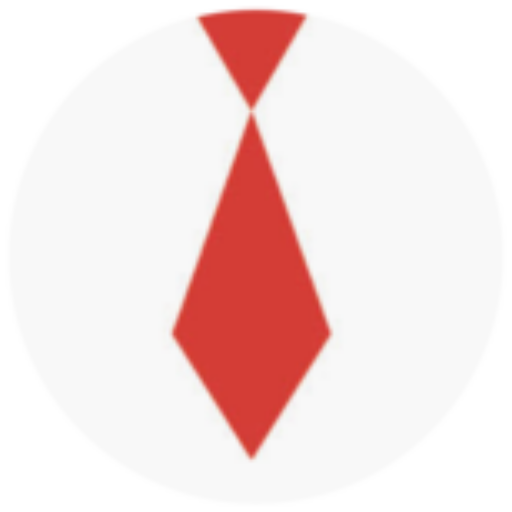Negli ultimi anni si è parlato molto di Smart Working, il lavoro intelligente. Si tratta, però, di una definizione corretta o che, nel tempo, si è rivelata meno accurata del previsto?
Dopo la pausa forzata del coronavirus a marzo 2020, lo smart working è diventata una comune pratica in moltissime aziende in Italia e nel mondo.
Quali sono gli effetti sulle culture organizzative delle aziende e a chi fa veramente bene lo smart working?
Nel mese di marzo del 2020 il mondo è stato sconvolto dalla pandemia di Coronavirus che ha segnato un cambiamento epocale per le economie mondiali ma soprattutto ha delineato una linea di confine “traumatica” tra il prima ed il dopo nelle relazioni umane.
Passaggio traumatico veramente, dal momento che, come nella sua etimologia, in psicologia il termine indica un “ferita” che attraverso una forte carica emozionale interrompe la continuità dell’esperienza psichica umana tra il prima ed il dopo l’evento scatenante.
La drammatica diffusione del virus ha imposto rigide regole di sicurezza tra le quali il distanziamento coatto tra gli individui, con conseguenti drastiche misure intraprese in ogni contesto sociale, primo fra tutti quello lavorativo.
Recenti dati statistici dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, rilevano come nell’Unione Europea (1), mediamente 3 dipendenti su 10 operino a distanza gestendo in autonomia i propri impegni e la programmazione e pianificazione delle attività lavorative ad essi affidate: si tratterebbe dunque di una vera panacea per il lavoratore e fonte di indubbia soddisfazione dell’imprenditore in termini di efficienza.
A suffragio delle teorie sostenitrici dell’efficacia dello smart working, ci sono molte iniziative volte a promuoverne l’utilizzo.
In Nuova Zelanda, ad esempio, esiste una organizzazione no profit chiamata “4 Day Week Global” (2), fondata nel 2019 che è nata con lo scopo di dimostrare che è possibile essere produttivi lavorando 4 giorni a settimana.
Programmi pilota di tale approccio sono stati sperimentati, sembrerebbe con successo, in aziende collocate in nazioni come Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, con il beneficio dei dipendenti che risulterebbero meno stressati e meno inclini ad ammalarsi.
Anche le aziende interessate dall’esperimento avrebbero beneficiato delle misure intraprese con la diminuzione del tasso di assenteismo, riduzione del turnover e la stabilità della produttività: tutto bellissimo.
Insomma, lo smart working sembrerebbe accontentare tutti, ciononostante, pur essendo una modalità di lavoro ritenuta idonea a ottimizzare i tempi di lavoro e la produttività, il lavoro a distanza, con la contropartita di migliorare la qualità della vita di chi vi aderisce, ha mostrato luci ed ombre se si analizzano gli effetti di questa pratica sulle culture organizzative e non di meno sugli individui stessi.
Un recente studio pubblicato sull’ International Journal of Environmental Research (3) evidenzia che, oltre che vantaggi, lo smart working potrebbe nella sua fattispecie, generare dei rischi per la salute mentale ed anche fisica dei lavoratori.
L’isolamento, le condizioni caratterizzate da monotonia a causa della carenza di relazioni, possono suscitare sentimenti di assenza di riconoscimento, blocco del percorso di carriera e stasi nell’evoluzione professionale con conseguente sintomatologia fisica e psicologica.
Tali condizioni, sulla distanza, potrebbero altresì essere la causa di un sostanziale impoverimento delle relazioni tra lavoratore ed azienda, ma anche di un peggioramento della salute mentale dei collaboratori con ricadute sociali ed economiche da non sottovalutare (4).
A tutto quanto esposto si aggiunga il possibile rischio di un sostanziale impoverimento del contributo fondamentale fornito dai collaboratori alla formazione della cultura organizzativa, con il rischio di generare aziende nelle quali il personale non vive pienamente il sentimento di appartenenza a causa della mancanza di vere interazioni personali.
Se dunque la cultura organizzativa rappresenta l’insieme dei valori condivisi che si manifestano attraverso atteggiamenti, comportamenti e pensieri di chi collabora all’interno dell’azienda, forse vale la pena ripensare al valore delle relazioni che sono anch’esse patrimonio aziendale perché ne definiscono la risorsa primaria, fonte inesauribile dell’energia necessaria alla realizzazione del business.
Sotto il profilo psicologico resta dunque determinante favorire le relazioni, viaggiando ovviamente allo stesso passo del progresso che ci vede connessi anche stando dall’altra parte del mondo senza però intendere per benessere il distanziamento del lavoratore dal luogo di lavoro.
Sarà opportuno dunque ricordare, che il primo segnale di benessere aziendale sono proprio le relazioni attive e positive e che esse sono alla base del clima e del senso di appartenenza alla comunità professionale.
Non facciamo retorica dunque, se diciamo che il vero benessere delle risorse umane e la cultura organizzativa sono il vero patrimonio di un’ azienda.
Il successo di un’ impresa è pertanto rappresentato, prima di tutto, dalle persone e dalle loro idee condivise, dalla creatività, dall’umanità e da strette di mano senza le quali non esiste vero progresso il quale non si realizza certo stando (troppo) lontani gli uni dagli altri.
Articolo realizzato grazie alla collaborazione della dott.ssa Donatella Orsini, psicologa con esperienza pluriennale nella gestione delle risorse umane.
Bibliografia:
(1) ILO (International Labour Organization) Practical Guide on Teleworking during the COVID-19 Pandemic and Beyond. ILO; Geneva, Switzerland: 2020.
(3) Figueiredo, E., Margaça, C., Hernández-Sánchez, B., Sánchez-García, J.C.,”Teleworking Effects on Mental Health—A Systematic Review and a Research Agenda”: 2024.
(4) Costin A., Roman A.F., Balica R.S. Remote work burnout, professional job stress, and employee emotional exhaustion during the COVID-19 pandemic. Front. Psychol.: 2023.