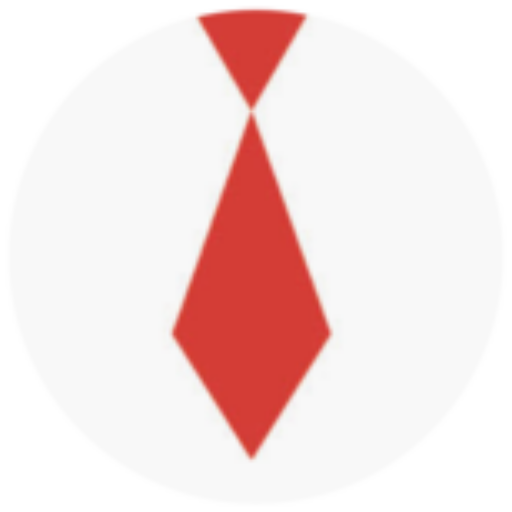I millennial, i giochi e la Brexit
Luglio 2016. In un pomeriggio uggioso, io e la mia compagna decidiamo che è venuto il momento di comprarci un gioco da tavolo. Abbiamo convenuto che questo potesse essere un ultimo passaggio decisivo prima della convivenza, capace di mettere alla prova lo stare insieme e di verificare la possibilità di scannarsi alla seconda partita. Nessuno dei due a casa ha la televisione e i giochi di società rappresentano per entrambi quelle serate della nostra infanzia in cui la media borghesia, invitando a casa gruppi di amici, trascorreva intere ore davanti a Monopoly e Scarabeo. La generazione dei nostri genitori (quella che Moretti definirebbe “Generazione Happy Days”) ci ha cresciuti confidando che i giochi da tavolo, insieme allo sport, bastassero a fare dei propri figli delle brave persone.
Dopo una lunga diserzione sull’esistenza o meno del termine “giocheria” (lei, classe ’93, sostiene che non esista), ha inizio la nostra ricerca. Scopro che a Torino di giocherie, o comunque negozi di giocattoli, ce ne sono più o meno tre e tutti fuori dal centro. Decidiamo di camminare: qualcosa troveremo. In via Po ci imbattiamo in un negozio di peluche e suppellettili, nel cui seminterrato sono nascosti quelli che la commessa definisce “giochi classici”. In mezzo a muri di bambole, cucine per bimbe e travestimenti di carnevale, finalmente troviamo i pezzi da novanta (in tutti i sensi, risalendo la mia ultima partita a Risiko a quel decennio). La scala va dai giochi di percorso, come il Backgammon, Castello Incantato, Non t’arrabbiare, il Gioco dell’oca, Pachisi e Scale e serpenti, ai giochi di simulazione commerciale come il Monopoly e tutti i suoi derivati. Dai giochi di bluff come Bang!, Citadels, Poker e Stai Away!, a una decina di tipi diverso di RisiKo!. Incantati cerchiamo di recuperare nella memoria i ricordi più belli di quelle serate di vent’anni fa. Ci vergogniamo un po’ a dire alla commessa che cerchiamo un gioco per noi due e quindi lo spacciamo per un regalo (alla cassa ce lo faremo anche incartare). La mia compagna chiede notizie del Paroliere, ma scopriamo che è fuori commercio da parecchi anni. La commessa si rivela una grande esperta, una giocatrice accanita che ha giocato a ogni gioco almeno una volta e ci racconta quali l’hanno divertita di più e le peculiarità di ciascuno.
Ma il nostro entusiasmo si spegne non appena voltiamo le scatole colorate e scopriamo il prezzo. Nessun gioco infatti costa meno di 50 euro. Imbarazzati, fingiamo di essere ancora interessati alle descrizioni della commessa, ma appena lei si gira ci guardiamo con un sorriso tirato. Poi prendo il coraggio a quattro mani e le dico “Ma qualcosa di più semplice? Non per farne una questione di prezzo, ma se aveste qualcosa di più alla mano, di più….piccolo.” La commessa comincia a bofonchiare dei “più piccolo, più piccolo”, mentre si accovaccia verso i ripiani più bassi a scorrere il dito sui cartoni. Poi finalmente riaffiora con una scatolina rossa in mano: “Scarabeo Flash”. Flash? Le chiediamo all’unisono? “Sì, è come uno Scarabeo, ma con la clessidra e meno pezzi. Una partita dura un quarto d’ora in media.” Prezzo 25 euro. Fingiamo per qualche minuto di essere ancora indecisi su Monopoly e ci avviamo con lo Scarabeo Flash alla cassa.
Pochi giorni dopo, insieme a 734 milioni di europei, ci risvegliamo nell’orrore di Brexit. Il referendum britannico spacca il continente a metà, tirando una linea impietosa tra due generazioni. Ne Gli sdraiati di Michele Serra, il protagonista lavora a un romanzo intitolato La Grande Guerra Finale, nel quale Giovani e Vecchi si sarebbero affrontati in un ultimo e decisivo conflitto globale (pur non riuscendo a decidere quale delle due parti avrebbe prevalso). La rabbia che nei giorni dopo il referendum esplode dalle voci dei giovani britannici sembra estrapolato da quell’ipotetico libro. L’editoriale di Mario Calabresi su Repubblica, all’indomani dei risultati di Brexit, cita una ragazza inglese che aveva votato Remain, ma non era riuscita a convincere i suoi a fare altrettanto: “Verrà il turno della nostra generazione e allora torneremo”.
Mi trovo presto a ripensare alla mia esperienza in giocheria e mi domando: dov’è finita quella spensieratezza, quella inesauribile voglia di pace della “Generazione Happy Days”? Dove la certezza che bastino due calci al pallone e un tiro di dadi a fare dei propri ragazzi un giorno dei padri di famiglia e degli elettori esemplari? I nostri genitori ci hanno educato all’Europa: perché togliercela ora? Dove, ai loro occhi, risiede il pericolo di questo grande gioco che ci hanno messo tra le mani? Perché hanno paura di condividere la bellezza dei loro giochi con i propri figli?
Quanto sono diventati costosi i giochi. Nella società dell’individualismo più sfrenato, dove ognuno pensa solo per sé, è vero: potremmo giocare a Ruzzle sui nostri smartphone tutta la serata e sì, trascorriamo un numero infinito di ore a mandare messaggi. Ma siamo anche la generazione delle community e del villaggio globale. Conosco ragazzi (e li conoscete anche voi), che per inseguire il loro sogno, attraversano ostacoli e privazioni inimmaginabili per i loro genitori. Umiliazioni alle quali mamma e papà non sono mai stati abituati: non trovare lavoro, fare stage non retribuiti (o scarsamente retribuiti) per interi anni, inviare curriculum senza neanche ricevere una risposta, venire costantemente trattati come minus habens. Non spetta a quella generazione decidere in quale Europa vivremo. Il gioco dell’individualismo, da noi, è passato di moda.
Ho in mente il finale del film di Montaldo “Sacco e Vanzetti”. Prima di morire, Nicola Sacco scrive una lettera al figlio, che termina dicendo: “[…] Possono bruciare i nostri corpi oggi, ma non possono bruciare le nostre idee: esse rimangono per i giovani del futuro, per i giovani come te. Ricorda figlio mio: la felicità dei giochi non tenerla tutta per te.”
Infondo, siamo una generazione un po’ così. Abbiamo comprato lo Scarabeo che costava la metà, ma non usiamo la clessidra.